Gli anni ‘80 hanno rappresentato un vero e proprio spartiacque per il vino italiano e in particolare per il Chianti Classico. Da un lato si assiste al fenomeno Super Tuscan con produttori che cercano nuove espressioni per i vini del territorio uscendo dai disciplinari con produzione dei vitigni tradizionali in purezza o in uvaggi con proporzioni differenti, introduzione di vitigni internazionali, uso di tecniche di vinificazione e affinamento diverse. Dall’altra parte il Chianti Classico avverte l’esigenza di cambiare le regole per privilegiare e incrementare la qualità salvaguardando tipicità e tradizione. Ci si era accorti che vi era cura meticolosa in cantina, da parte di enologi ed enotecnici, ma a questa non corrispondeva altrettanta cura in campagna. Spesso venivano impiegati cloni di Sangiovese non di origine toscana perché più produttivi, ma che davano vini dal profilo organolettico meno espressivo.
Rispondendo a questo bisogno di rinnovamento, nasce, nel 1987, il progetto Chianti Classico 2000, il più grande progetto fatto mai in Italia in viticoltura, avviato dall’allora Presidente del Consorzio Lapo Mazzei durante un convegno a Greve in Chianti.
“Sono del parere che sia proprio l’epoca giusta per cimentarci in una prova del genere – aveva dichiarato Lapo Mazzei in quell’occasione – Dalla tradizione bisogna infatti ora passare, attraverso le più moderne tecnologie, al razionale aiuto della scienza. All’esperienza bisogna adesso fornire il supporto della ricerca e della sperimentazione … A fronte di costi di impianto e di produzione sempre più elevati e a conoscenza degli orientamenti del mercato, è indispensabile, per affrontare con tranquillità il futuro, perseguire e raggiungere il massimo della qualità nelle nostre produzioni”
La finalità era quella di studiare le tecniche agronomiche e il materiale vegetale, per ricavare nuove informazioni utili per apportare un cambiamento nella qualità della produzione migliorando e razionalizzando la gestione del vigneto, le tecniche di coltivazione.
Elaborato dal Consorzio Vino Chianti Classico nel settembre 1987, è stato approvato dal Ministero dell’Agricoltura e dalla Regione Toscana nel 1988, ottenendo anche il riconoscimento della Comunità Europea che lo ha finanziato.
La prima parte del Progetto, ha avuto una durata di 16 anni, suddivisi in tre cicli, durante i quali si è provveduto a verifiche e controlli sul campo con raccolta ed elaborazione dei dati fino alla pubblicazione e alla divulgazione dei risultati. Ha visto la collaborazione del Comitato scientifico del Consorzio, della Facoltà di Agraria dell’Università di Firenze, che ha curato gli aspetti economici, agronomici e le verifiche enologiche, e della Facoltà di Agraria dell’Università di Pisa, che si è occupata degli aspetti viticoli, patologici e sanitari.
Per la ricerca viticola sono stati impiantati 16 vigneti sperimentali per una superficie complessiva di 25 ettari, per la ricerca enologica sono state coinvolte 5 cantine per microvinificazione di ogni singola tesi sperimentale; contemporaneamente sono state installate 10 stazioni agrometeorologiche nelle zone più significative del territorio sotto il profilo climatico.
Sono state individuate e verificate sul campo sei tematiche fondamentali per la realizzazione di una viticoltura moderna:
– Verificare il comportamento agronomico ed il valore enologico di alcuni cloni omologati di alcuni vitigni a bacca nera (Sangiovese, Canaiolo, Colorino e Malvasia Nera) già in uso sul territorio e compresi nell’uvaggio del Chianti Classico.
– Indagare sulle caratteristiche di una serie di portinnesti, sia quelli attualmente più utilizzati, in quanto ritenuti più adatti all’ambiente pedoclimatico chiantigiano, che quelli mai sperimentati nel territorio del Chianti.
– Studio della densità di piantagione più idonea in relazione all’ambiente e al livello produttivo desiderato. Si è trattato, in pratica, di determinare con metodologie sperimentali il rapporto tra le densità di piantagione e il comportamento vegeto-produttivo del vigneto con particolare riferimento alla qualità delle uve e del vino.
– Studio delle forme di allevamento allo scopo di conoscere l’incidenza delle stesse sulla qualità delle uve e dei vini prodotti, prendendo anche in considerazione la necessità di ridurre i costi della potatura manuale.
– Approfondimento delle tecniche di gestione del suolo da adottare nel vigneto con lo scopo di valutare la possibilità di attuare l’inerbimento controllato per migliorare la gestione del vigneto e nello stesso tempo contribuire anche alla difesa dell’ambiente, limitando il fenomeno dell’erosione.
– Selezione clonale dei principali vitigni utilizzati nella produzione del Chianti Classico (Sangiovese, Canaiolo e Colorino). Lo studio ha portato a individuare 239 presunti cloni, fra i quali sono stati selezionati 24 di Sangiovese, 8 di Canaiolo e 2 di Colorino che, risultati esenti dalle principali malattie virali, sono stati poi sottoposti ad ulteriori controlli tecnologici. Parlando pionieristicamente di sostenibilità e resistenza naturale alle malattie, si sono valutati i cloni che potevano adattarsi meglio al nuovo clima, caratterizzati da grappoli più piccoli, leggermente spargoli per essere meno soggetti alla botrite, acini con buccia spessa ricca di colore e polifenoli, ma anche ricchi di acidità. Sottoposti a microvinificazione, i vini ottenuti sono stati valutati dal punto di vista organolettico per corrispondenza alla tipicità e potenziale espressivo.
Al termine del periodo di sperimentazione si è giunti così all’omologazione di sette nuovi cloni di Sangiovese e di uno di Colorino, e alla relativa iscrizione nel Registro nazionale delle varietà di vite con la sigla “Chianti Classico 2000” (CCL 2000). A questi sono stati successivamente aggiunti altri due cloni di Sangiovese e uno di Canaiolo.
Lo studio, che purtroppo ha avuto più risonanza mediatica all’estero che in Italia, ha portato al reimpianto di circa il 60% dei vigneti con i cloni omologati, le densità di impianto individuate come ideali, il guyot come forma di allevamento preferenziale per garantire qualità e longevità della vite, l’applicazione di tecniche di gestione della vigna e del suolo che si sono rivelate le più adatte al territorio.
La degustazione leggere Chianti Classico a Milano
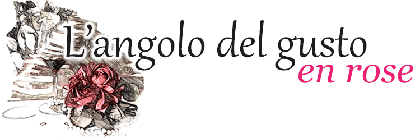

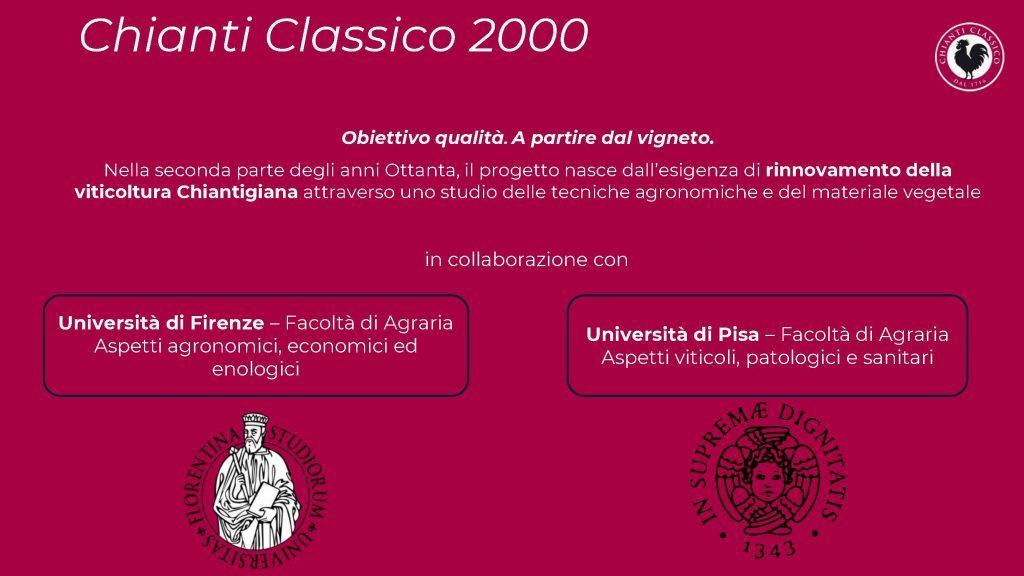





Comments are closed.